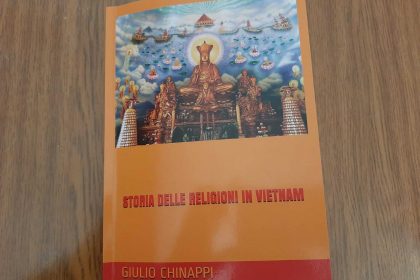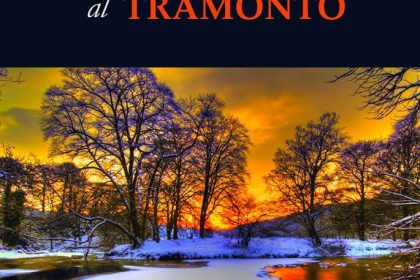n una società nella quale la “spettacolarizzazione”, in particolare anche quella del dolore, è una dinamica con la quale si convive agilmente, è facile fraintendere l’obiettivo di una persona che intende portare oltre il senso ultimo più condiviso un processo di racconto che scaturisce dalla propria malattia. Come far comprendere che l’obiettivo non ha a che fare con la “compassione” o con la volontà di apparire, bensì con l’intimo e nobile sentimento di proporre un nuovo modo di leggere la vita – senza salire su alcuna cattedra – e ciò che può, legittimamente, provocare una “crisi” – come la diagnosi di un tumore?
Credo che una riflessione simile si annidi nel retroterra dell‘ultima, toccante e potente, narrazione della scrittrice Michela Murgia che, culturalmente, prima ancora che letterariamente, compie un’operazione delicata e superlativa: accoglie il progresso comunicativo dei social e li sceglie come arena per far sbarcare la sua diagnosi di cancro e ne fa un letto accogliente per il suo nuovo romanzo Tre ciotole – rituali per un anno di crisi, nel quale diverse storie di “crisi” si incastrano, portando i loro protagonisti a cambiamenti radicali e a scoprirsi in grado di sopravvivere emotivamente, ognuno come vuole, ognuno come può.
La storia della sua diagnosi – ed è qui che il testo diventa “poesia del dolore”, ovvero trova nella forza della complessità umana la capacità di elevare e prestare parole che oltrepassino l’individualismo dell’improvviso dolore, della sorprendente tragedia – è alla stregua della storia di donne che portano in grembo un bambino senza amare i bambini; di donne che amano figuri di cartone e diverse altre. Qualcuno potrebbe pensare che le questioni sono imparagonabili, che è un azzardo, addirittura intercettare una “banalizzazione” di una diagnosi onocologica, ma non è così…
Contemplare le “crisi” e il dolore, epurandolo dall’esclusività del dolore che scatta quando pensiamo che qualcosa che non potesse accaderci prende, invece, forma, è il tentativo più riuscito di superare quella struggente frase del testo di Disamistade – E per tutti il dolore degli altri è dolore a metà – di Fabrizio De Andrè.
E’ come se la Murgia volesse mettere in luce la dignità di ogni dolore, tutti i dolori, ma anche ricondurli – e qui siamo nel meravigloso iperuranio della riflessione – ad una coesistenza ineluttabilmente legata alla complessità degli “esseri pluricellulari”. Come facesse parte del gioco, sollevandoci da quell’ immancabile interrogativo che porta a chiedersi: «dove ho sbagliato?».
«Siamo esseri complessi, signora…non credo si possa definire la questione in termini di sbagli suoi. Gli organismi sofisticati sono più soggetti a fare errori. E’ il sistema che ogni tanto si ingarbuglia, la volontà non c’entra».
E più avanti, lo stesso personaggio – l’Oncologo – chiarisce ancora meglio.
«Mi ha detto che sccrive romanzi, un bellissimo lavoro, ma è molto complicato. Nessuna specie in natura lo sa fare, solo gli esseri umani. Conosce altre lingue oltre l’italiano?»
«L’inglese, il francese, più o meno lo spagnolo… sto studiando il coreano.»
«Preferirebbe non saper fare nessuna di queste cose a patto di non ammalarsi mai? Gli organismi unicellulari non sviluppano neoplasie, ma non imparano lingue. Le amebe non scrivono romanzi. »
Con “Tre ciotole” ha messo se stessa a disposizione della narrazione, della riflessione, ha fatto della sua storia personale un “cambio di stagione”, ha svestito la storia dagli aggettivi “sua” e “personale”. Ha fatto delle pagine del libro, gli abiti appesi ai rami di una foresta di consapevolezze – non tutte percorse.
Murgia ha fatto la scrittrice fino in fondo. Accettando, prima ancora, il suo essere umano fino in fondo.
Per me, che pur mi perdo tra tanti perchè, una “lezione” condivisa ed imperdibile.