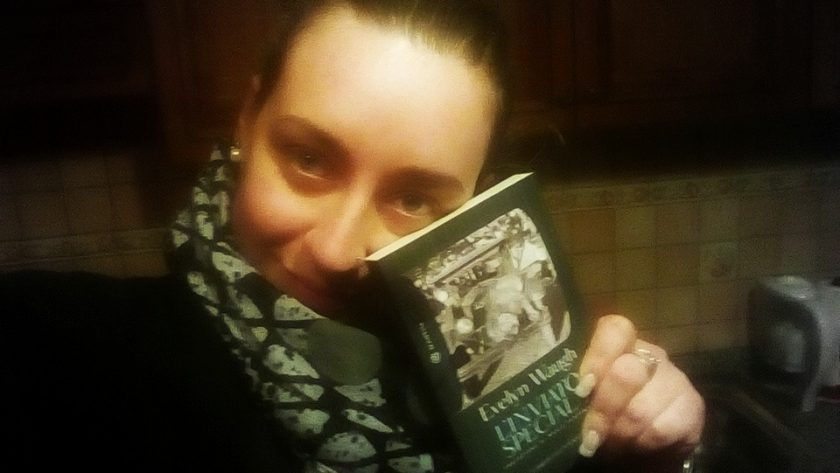“Fate luce e la gente troverà da sola la strada”. Introdurre la lettura de “L’inviato speciale” di Evelyn Waugh ( Bompiani ), con questa frase dell’America Society of News Papers Editors ( Nord America) permette di poter trattegiare le ipotetiche linee all’interno delle quali sciogliere un discorso critico sull’attuale condizione del giornalismo e dei giornalisti.
Il testo di Waugh è davvero divertente. Un gioco di sovrapposizione di persone, a causa del loro cognome, fa firmare ad un improbabile inviato speciale alla prima esperienza, William Boot, uno scoop a Ismaelia, immaginario stato nel cuore dell’Africa in preda ad una crisi economica, che lo consegna ad una celebrità talmente inattesa che finisce col rifuggirla. Su questo scenario dettagliatamente descritto, che non di rado strappa qualche risatina nella comicità che traccia tipicamente il buffo scambio di persone, si muove, dunque, capovolgendo la materia, un uomo inesperto che fondamentalmente però si attiene ai dettami del giornalismo più di quanto non facciano i suoi colleghi scafati: non scrive fintanto che non c’è nulla da vedere, quindi, da riportare. Quando lo fa, firma lo scoop, quasi inconsapevolmente.
Ciò che è veramente entusiasmante, però, è tutto l’arco riflessivo che si instaura nelle pagine, o meglio nel non detto delle pagine, in merito alla professione giornalistica. Fra tutte come si modula il lavoro di chi costa denaro ad una redazione che ti spedisce a chilometri di distanza per seguire scenari lontanti di cui renderne un’immagine quanto più veriteria, accorciando così le distanze. Non lesina neanche di sospingere pensieri circa la qualità del lavoro, la deontologia con cui lo si svolge, le capacità di relazionarsi con le imprescindibili fonti. Ed ancora com’è visto dalla società il ruolo del giornalista e quale peso specifico può avere uno scoop.
E’ necessario aggiungere in premessa che questi interrogativi si contestualizzano all’anno della stesura, ovvero il 1938. Un dato indispiensabile che crea la prima domanda: dopo più di cinquant’anni ancora le stesse sono le questioni?
Ad ogni rivoluzione, come quella segnata dal digitale, è come ripartire da un anno zero, forse, questo è sufficiente a giustificare il perchè dell’attualità di un testo che interroga, come negli anni non si è mai smesso di fare, la professione.
La verità, la lealtà nei confronti dei cittadini, la regola della verifica che suggella l’obiettività come metodo e non come modo d’essere, l’indipendenza dagli argomenti, che non significa indifferenza. La funzione di “whatch dog”, rendere interessante ciò che è significativo, lavorare secondo coscienza. Nonchè le nuove tecnologie che, di base, hanno riportato, il giornalismo a quella dimensione compartecipata, dalla quale d’altro canto era nato: i forum, i commenti, i like, in effetti, permettono le critiche del pubblico e di conseguenza, una sorta di intermediazione.
Insomma, semplicemente, oggi, come ieri, nel vulcanismo dei nuovi strumenti, al giornalista e al giornalismo si chiedono le medesime cose: soddisfare con lealtà la fame di consapevolezza umana che aiuti a direzionare la vita di ogni singolo individuo.
Un gioco sul filo del rasoio, in cui, per rendere l’idea, anche le emozioni sono informazioni, che spesso bisogna tenere in tasca. Un filo di lana su cui i giornalisti camminano spinti dall’osmosi emotiva, dalla sindrome della “carta moschicida”, dai dubbi, dalle negazioni, in un regno apparentemente dorato, il cui vertice si stringe sempre di più, differentemente da una base che si dilata, abbracciando insoddisfatti ed improvvisati cronisti. Una struttura sempre più viziata da logiche di marketing che suggeriscono di definire i lettori e gli spettatori “clienti”, capirli “strategie di mercato” e le notizie “servizi alla clientela”.
Ecco leggendo “L’inviato speciale”, ci si accorge di quanto quelli che conservano intatto lo spirito del mestiere siano davvero “speciali”, anche se la simulataneità despazializzata nel mare magnum del World Wide Web, occhio e croce, sposta più i “fatti” ( o “prodotti”) che i professionisti.
Oggi come allora, accanto a colui che si è adagiato sull’evoluzione strumentale, a quello che si è inginocchiato con l’informazione inchinata al potere del mercato, della poltica o del braccio di ferro all’occorrenza. Accanto a quello che dimentica la passione per servire un padrone che non sia la società, a quello che inventa immagini che forviano la realtà sottraendo strumenti al futuro, c’è il “fenomenale funambolo” che sopravvive: che riscatta Boot, a qualsiasi dei tre ( John, William o Theodore ) della trama si voglia pensare, e fa prendere un po’ meno in giro il giornalismo.
“L’inviato speciale” è l’elegante ed ironica storia di un giornalismo in decadenza ( Waugh è considerato il più grande scrittore satirico inglese), ma il fenomenale funambolo è la prova che qualcuno cerca ancora, come sempre, più o meno consapevolmente, di arrestarne la caduta.