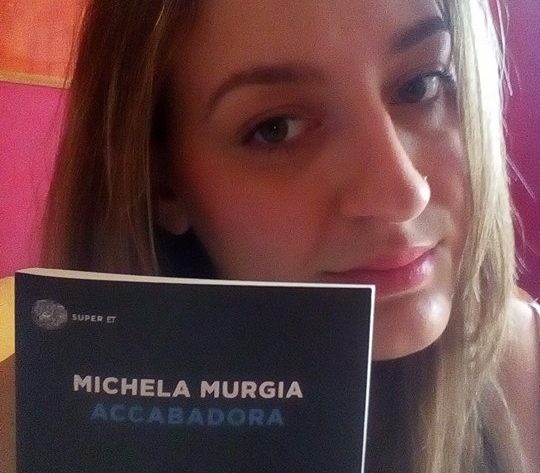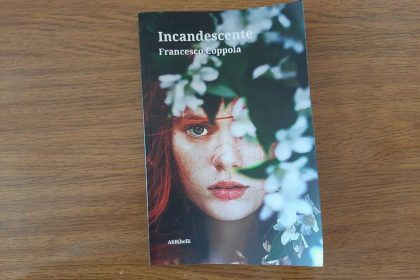Si possono raccontare storie descrivendo luoghi e personaggi che rimangono intrappolati nella carta, poi ci sono storie che si alimentano dell’atmosfera che la penna è in grado di costruirgli intorno, di cui sono madri e figlie. Sono le storie che prendono vita nell’immaginazione e sembrano venire spedite da un passato che le getta di prepotenza nel futuro, a cui sperano di riportare un po’ di sana essenza. Storie come “Accabadora” di Michela Murgia.
Vuoi che la Sardegna è una roccia ancestrale, vuoi che l’eutanasia è un argomento vitale per la cronaca degli ultimi anni, recuperare dal vortice di incomprensione ed etica arcaica una sacrosanta morale della morte, fa del romanzo della Murgia un capolavoro di armoniosa sincronia di immagini, tempo e spazio.
“Acabar” in spagnolo significa “finire” ed in sardo “Accabadora” è “colei che finisce”: non un’assassina, né una strega malefica, semplicemente ( si fa per dire!) una donna la cui “pietas” raggiunge livelli decisamenti desueti e, mista ad una pura amorevolezza per l’umanità trattenuta nell’anima, aiuta il destino a compiersi. A volgere al termine, perchè lei è l’ultima madre.
Lei è Tzia Bonaria, la piccola lei è Maria, la sua fill’ e anima. Vivono come mamma e figlia da quando l’anziana sarta l’ha vista rubacchiare delle ciliegie in un negozio e macchiarsi della colpa schiacchiandole nella tasca del suo abitino bianco, e siccome « le colpe, come le persone, iniziano a esistere se qualcuno se ne accorge » , l’ha presa con sé. D’altro canto fino a quel momento Maria, per la madre vedova era stata solo la “terza” o “l’ultima” delle figlie, nulla di più, mentre Tzia Bonaria sentiva di avere molto da insegnarle: cucire le asole, gli orli, ma soprattutto come accogliere la vita, così come la morte.
Glielo indica giorno dopo giorno, nei piccoli sguardi, in un concetto di giustizia che le porge oltre il bene ed il male, e quando, faccia a faccia le ricorda, anzi ci ricorda, come si viene alla luce.
«Ti sei tagliata da sola il cordone? Non ti hanno forse lavata e allattata? Non sei nata e cresciuta due volte per grazia di altri, o sei così brava che hai fatto tutto da sola? » […]. « Altri hanno deciso per te allora, e altri decideranno quando servirà di farlo. Non c’è nessun vivo che arrivi al suo giorno senza aver avuto padri e madri a ogni angolo di strada, Maria, e tu dovresti saperlo più di tutti. L’anziana sarta parlava con la sincerità con cui si danno le confidenze agli sconosciuti sul treno, sapendo che non si dovrà sopportare mai più il peso dei loro occhi ».
E’ una storia cosparsa di fuochi fatui e sarebbe banale pensare che sia un libro che parli di morte, tutt’altro, è una storia in cui c’è vita ad ogni angolo. C’è in tutto il cibo tipicamente sardo che le donne sono impegnate a preparare: nei gueffus, nei pabassinos, nel pane. C’è nei lamenti strazzianti delle donne che vanno ritualmente a piangere i defunti pregando attorno a loro con l’abito più bello che hanno a disposizione nell’armadio, perchè i riti della morte non meritano meno attenzione di qualsiasi altro.
E’ una storia di comprensione e libertà, di quella che solo una terra selvaggia e atavica come la Sardegna, con i suoi profumi e le sue cerimonie sanno incarnare. E’ la massima espressione di quella libertà che non eserciti neanche venendo al mondo, visto che accade per volontà altrui, senza poter scegliere dove, quando, come e, soprattutto, perchè, ma che si può riscattare decidendo quanto meno in che “rigo” del discorso mettere il “punto”. Un’ “espressione ortografica” che passa tra la saggezza delle rughe di un viso che nella sua solitudine, nell’assolutezza della sua vita, ne trattiene un sapore ultimo: di salsedine sarda soffiata dal Maestrale su una consapevolezza culturale che possa abbracciare l’oggi e, ancor di più, il domani.