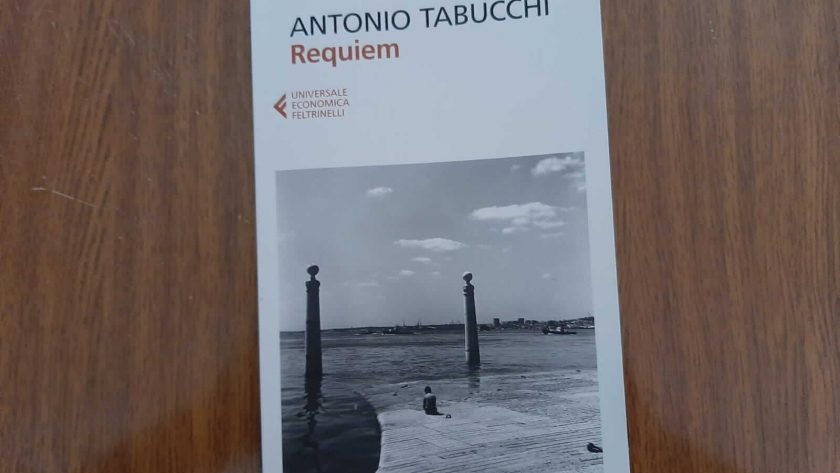“Buonanotte, dissi, o meglio addio: addio. A chi, o a che cosa, stavo dicendo addio? Non lo sapevo bene, ma era quel che mi andava di dire ad alta voce. Addio e buonanotte a tutti, ripetei. Reclinai il capo all’indietro e mi misi a guardare la luna”.
Riportare queste poche frasi pronunciate da “io” nel piccolo e prezioso lavoro di Antonio Tabucchi Requiem – Un’allucinazione ( Universale Economica Feltrinelli, 2019) è il miglior modo di rendere la dimensione del viaggio intimo e onirico che il protagonista compie, attraverso se stesso e i suoi “fantasmi” in una domenica di luglio in una caldissima Lisbona.
Per scrivere queste travolgenti pagine l’italiano Tabucchi, tra i più grandi scrittori europei del Novecento, ha scelto il portoghese, non solo per rendere omaggio al Portogallo, ma soprattutto perchè “aveva bisogno di una lingua differente: una lingua che fosse un luogo di affetto e di riflessione”. Un passaggio che merita di essere sottolineato per restituire l’idea di quanto un tema così caro alla letteratura, il “viaggio” appunto, appartenga in questa esperienza ad una dimensione così profondamente endemica da aver bisogno, per l’appunto, di una sorta di lingua eletta per poterla far vivere al di fuori.
Sostituendo l’ “inconscio” all’ “anima”, “io” parte a mezzogiorno da una torrida Lisbona e – con la fatalità che tipicizza la concatenazione di eventi che finiscono con l’essere racchiusi nel “caso” – seguita ad assecondare le tappe e gli incontri di questa giornata che lo condurrà all’incontro conclusivo con un illustre personaggio scomparso che, come da consuetudine per tutti i fantasmi, lo aspetterà solo alla mezzanotte. In quel punto preciso tra la fine e l’inizio di un nuovo giorno, di una nuova avventura e – perchè no – di una nuova consapevolezza.

Così tra coscienza ed incoscienza, ritorna su alcune tappe fondamentali della sua esistenza: le rievoca, le attraversa e le “chiude” come un cerchio, cercando la sublimazione di reticenze che tormentano la sua interiorità e, quindi, per lo più rispondendo a se stesso – ad alta voce – rispetto ad alcune grandi domande che – come vuoti – aleggiano sul suo presente.
Nelle dodici ore che “io” vive si mescolando passato e presente, vivi e morti, prende forma – insomma- un viaggio in grado di sfidare il tempo, di oltrepassarlo mescolandone le dimensioni canoniche, lì nell’intimità, nell’inconscio di un uomo – dove la variabile temporale è per l’appunto solo una variabile e certi sentimenti finiscono al cospetto dell’eternità, pullulando sotto una pelle che alle volte non riesce neanche più a contenerli – nonostante la fatica e i pori aperti della sudorazione che libera qualsiasi corpo dalle sue tossine ma non dalla sensazione di ciò che si è lasciato “aperto”, “sospeso”.
Quello che Tabucchi fa compiere in Requiem ad “io” è il “viaggio” che più o meno ognuno di noi compie, a volte del tutto inconsapevolmente, per mettere un punto a certe “faccende”, ad alcuni “momenti”; la sua forma narrativa diaristica lo rende ancora più condivisibile e misterioso, con la sensazione che lascia di entrare davvero in un mondo normalmente inaccessibile agli altri, al di fuori da qualcun’altro.
E’ forse inquieta, probabilmente lancia una sfida a chi non si è ancora guardato dentro, spaventa quest’ultimi richiamando l’importanza di farlo, ma cos’altro ha da fare uno scritto vero, autentico, se non questo? Requiem ci ricorda che la vita presenta sempre il conto, emotivo prima di tutto, di ciò che viviamo e di ciò a cui ci sottraiamo e, la sua grande bellezza, sta nella “leggerezza” con la quale racconta la fatica di fare ammenda di questa grande verità. consegnandola ai suoi lettori.
“Non consiglierei a nessuno di parlare con i fantasmi, è una cosa che non si deve fare, ma a volte bisogna, non so spiegarlo bene, è anche per questo che sono qui”.
Quindi, Requiem, perchè la “morte” è parte della vita e la vita deve rendere pace alla “morte”.